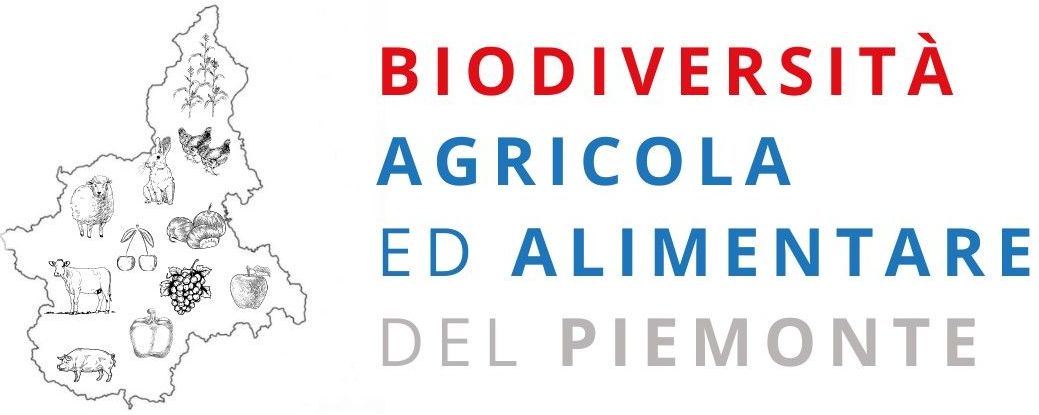Biodiversità - Agricola Piemonte
Specie
Capra Hircus
Cenni storici
L'origine della Capra Vallesana è incerta, sebbene alcuni studi suggeriscano che la razza potrebbe essere molto antica. Secondo alcune teorie, potrebbe essere stata introdotta da eserciti stranieri, mentre altre ipotizzano una discendenza da un ceppo lombardo. La Vallesana è principalmente associata alla Svizzera, in particolare alla valle di Visp, nei dintorni di Zermatt, che costituisce il centro principale di allevamento. In Italia, è considerata una derivata della capra svizzera "capra del collo nero". La razza fu introdotta in Italia, Francia, Austria e Germania nel primo quarto del secolo scorso. Alcuni ritengono che la Vallesana sia anche collegata alla razza inglese "Begot goat", la quale è famosa per essere stata donata a re Riccardo III nel 1380 e divenne la sua mascotte.
Situazione attuale
Attualmente, la Capra Vallesana è allevata principalmente nelle zone montane delle province di Vercelli e Verbania, in particolare nel Verbano Cusio-Ossola. In Svizzera, rappresenta circa il 7% del patrimonio caprino nazionale. Sebbene la produzione lattifera non sia la sua principale funzione, questa razza è apprezzata negli allevamenti amatoriali e nel turismo alpino, grazie al suo aspetto affascinante e al mantello bicolore. Ad oggi, sono stati censiti circa 1.152 esemplari.
Caratteristiche zootecniche
La Capra Vallesana è una razza rustica, ben adattata alla vita montana. Viene allevata principalmente per la carne, con la macellazione di capretti che pesano tra i 12 e i 25 kg. Nonostante la carne sia il suo utilizzo principale, questa capra possiede buone capacità lattifere. L'allevamento si basa principalmente su pratiche di pascolo, con alpeggio estivo e transumanza tra la bassa e media montagna e l'alta montagna. Durante l'inverno, le capre sono stabulate, mentre in primavera e autunno pascolano nei terreni aziendali, integrati con modeste quantità di fieno. Durante l'estate, vengono sfruttati gli alpeggi ad alta quota. La Vallesana è anche conosciuta come la "capra dei ghiacciai", per la sua straordinaria capacità di adattamento alle alte quote e ai forti sbalzi termici.
Caratteri morfologici descrittivi
La Capra Vallesana è di taglia medio-grande, con una corporatura robusta e ben proporzionata. L’altezza al garrese è di circa 83 cm nei maschi e 75 cm nelle femmine, mentre il peso medio è di 75 kg per i maschi e 55 kg per le femmine.
Il mantello è caratteristico per il suo colore bicolore: il pelo è lungo, fino a 35-40 cm nei capi adulti, coprendo completamente l'animale. Le parti superiori del corpo (testa, collo, arti anteriori, garrese fino a metà dorso) sono di colore nero, mentre il resto del corpo, comprese le zampe e la coda, è bianco. La divisione dei colori del mantello è nettamente visibile nella maggior parte degli esemplari, generalmente a livello della spalla o, meno frequentemente, a metà del tronco. La pelle è spessa e di colore chiaro.
La testa è proporzionata al corpo, con un profilo fronto-nasale rettilineo e orecchie di media lunghezza, dritte. Le corna sono lunghe e divergenti all'esterno, raggiungendo i 27-32 cm nelle femmine adulte e oltre i 50 cm nei maschi. Sono di colore nero. Sia nei maschi che nelle femmine è presente una barba e un ciuffo di peli sulla fronte, che è più pronunciato nei maschi.
Il collo è di media lunghezza, con una muscolatura media e la presenza di bargigli in entrambi i sessi. Il tronco è ampio, con un torace e un addome ben sviluppati, e una groppa leggermente spiovente. Gli arti sono robusti e solidi, con unghielli di colore nero sulle zampe anteriori e bianchi su quelle posteriori.
Caratteristiche trasformati
La Capra Vallesana è allevata principalmente per la produzione di carne, in particolare capretti leggeri da 12-15 kg e caprettoni pesanti da 20-25 kg, specialmente nelle zone dell'Alto Novarese e del Verbano Cusio-Ossola. La produzione di latte è destinata principalmente all'allattamento dei capretti. Tuttavia, la Vallesana è anche una buona lattifera: con una corretta selezione e alimentazione, può produrre circa 500 kg di latte in 200 giorni. Il latte ha un contenuto medio di grasso del 3,03% e di proteine del 2,87%.
Modalità di conservazione in situ o on farm
La Capra Vallesana è iscritta al Libro Genealogico delle razze caprine ed è soggetta a un programma di conservazione genetica. L'Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA) è coinvolta nella tutela della razza, che beneficia del sostegno dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR) per la conservazione delle razze autoctone a rischio. La gestione della riproduzione è mirata a preservare la variabilità genetica, mantenendo anche le caratteristiche di rusticità e frugalità che consentono alla razza di adattarsi alle difficili condizioni ambientali montane. Il recupero numerico della razza è stato in parte favorito dalle sue qualità ornamentali, che hanno stimolato l'allevamento anche al di fuori dell'area di origine. In ogni caso, è prioritario effettuare un censimento e una revisione dello standard di razza, includendo anche esemplari con colorazioni differenti, come il bruno e il grigio.
Contatti
Associazione Nazionale della Pastorizia (ASSONAPA)
Viale Palmiro Togliatti 1587 - 01155 Roma
Tel: +39 06 409001
Fax: +39 06 40900130
E-mail: tecnici@assonapa.com
R.A.R.E., (J.Errante)
C.so Agnelli, 32 - 10137 Torino
Tel: +39 011 6708580
Fax 011/4373944
E-mail:
info@associazionerare.it
Bibliografia di riferimento
- Associazione R.A.R.E. (n.d.). Ovini. Recuperato il [data di accesso], da https://www.associazionerare.it/ovini/
- Assonapa (n.d.). Programma genetico. https://www.assonapa.it/caprini/programma- genetico
- Bigi, D. e Zanon, A. (2008). Atlante delle razze autoctone. Edagricole.
- Commissione Europea (2023. Politica agricola comune (PAC). https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/cap-overview/cap- glance_it
- Fortina, R., Cornale, P., Renna, M. e Battaglini, L. (2017). Gli animali domestici delle Alpi. Blu edizioni.
- Ministero della Salute. (n.d.). Statistiche sul patrimonio ovicaprino in Italia. Vetinfo.
https://www.vetinfo.it/j6_statistiche/#/report-list/20
CONDIVIDI SU: